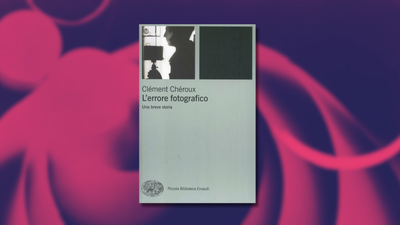Non mi sono mai considerato un fotografo documentarista. Il ruolo suggerisce che tu sia distante, emotivamente e fisicamente, dagli eventi fotografati. Non sei dentro l’immagine, ti limiti a registrarla passivamente. Io sono nell’immagine, credimi. Io sono nell’immagine, ma non sono l’immagine.
~ Bruce Davidson
Una vita passata a catturare la vita, quella vera e dei bisognosi, nella strade della sua città. Una vita passata a mettere la fotografia al primo posto, anche al di sopra degli affetti personali.
Di Bruce Davidson ne esiste solo uno e chiamarlo fotografo documentarista è come ferirlo nel profondo. Lui non ci sta a farsi appellare come tale: la sua fotografia va oltre la semplice registrazione dei fatti.
Si ritorna sempre lì, all’acerrimo scontro, ormai storico, tra due differenti visioni della fotografia: quella nata per essere uno strumento relegato alla sola salvaguardia della realtà, in una concezione prettamente boudleriana, e quella concepita per essere un mezzo di trasgressione nella vita di tutti i giorni.
La stizza di Davidson non nasce però da una questione totalmente di orgoglio, no, ma di rispetto nei confronti di un percorso della sua esistenza che lo ha visto mettere sempre tutto sé stesso in qualsiasi progetto da lui affrontato.

Perché vedi, la differenza sta tutta qui, nell’aver preso a cuore il proprio ruolo, quello del fotografo, e averlo plasmato a tal punto da unirlo saldamente con quello di uomo: oggi, come ieri, Bruce Davidson, è nelle sue immagini, pur non essendo fisicamente presente lì nella sua inquadratura.
Un concetto vecchio potrai pensare, ormai radicato nella coscienza di tutti, eppure ancora oggi c’è chi si prodiga tanto per acquistare le ultime macchine uscite sul mercato e si dimentica, che alla fine dei conti, quello che importa davvero, è essere presenti lì, nel momento in cui la realtà si mostra nella sua fragilità.
Presenti come fotografi, ma anche come essere umani. Perché la realtà per poter essere interpretata ha bisogno della partecipazione di due entità: quella incontrollabile della natura e quella sinestetica dell’uomo.

Il compito del fotografo è sacrosanto e ricco di responsabilità. Non varrebbe la pena combattere se la posta in gioco non fosse alta. Se devo rischiare, tanto vale mettere in mezzo tutto me stesso. Lo dico io, ma sotto sotto, so che lo stai pensando pure tu.
La documentazione è importante, ed è inscindibile dalla fotografia, Bruce Davidson ne è consapevole, come anche noi, ma il fotografare, e farlo bene, va oltre la semplice presa in diretta dello spazio circostante.
Per quello ci sono i fotografi della Domenica, o i giornalisti da strapazzo.
Dobbiamo essere in grado di trasmettere nelle nostre fotografie i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre angosce, sapendole rendere universali e collettive.
Questa è l’unica via per rendere la fotografia un’ancora di salvezza per la nostra esistenza e per quella degli altri, ed è inoltre quello che ci differenzia da tutti coloro che prendono in mano una fotocamera e che si fingono grandi maestri della materia.
Perché sotto sotto ogni fotografo è un narcisista. In ogni immagine c’è un pò di noi stessi e anche provandoci non saremmo in grado di escluderci a priori dalle nostre produzioni autoriali. Basta esserne consapevoli.

E ne è un esempio lampante la Farm Security Administration, nata per “documentare” la Grande Depressione Americana, e finita per dare luogo a delle vere e proprie interpretazioni autoriali, intime e profonde del tema.
Grandi fotografi, con un grande obiettivo e un grande cuore.
Quindi, quando sentite definire da qualcuno Bruce Davidson un fotografo documentarista, fermatelo, e ricordategli quanto sia il più lontano possibile da quel ruolo.
Bruce Davidson è un fotografo, e qualsiasi altro appellativo o aggettivo, bonario od offensivo che sia, perde di significato a confronto di quest’unica verità.